Andrea Bovara
le radici dell’anima
non riuscivo più a capire lo humour
di quello scherzo cosmico che era la mia vita
Emanuel Carnevali
E’ una vecchia storia, caro Andrea Bovara. Se racconti e riesci a sintetizzare in termini artistici lo sconcertante manifestarsi e i guasti di un’umanità sventurata e malvagia, non sei un accorto testimone del tempo, un indagatore dei meandri della natura umana ma un nichilista, un deplorevole profeta di sventura come se ne fossi tu la causa prima e non mero specchio – inesorabile, d’accordo – oltre che diretta e generica vittima come ogni essere umano.
Ciascuno scopre nelle opere d’arte che lo avvincono cicatrici del proprio passato e un’imprevista condivisione di sensazioni che generano spontanea attrazione verso l’artista, intuito allora come sodale, dotato del dono di rivelare tracce profonde del nonsenso universale del dolore e di fissarlo nella sua tragica grandezza.
La vicenda crudele e magnifica della vita umana si compendia nelle espressioni dei volti intensamente tracciati da Andrea Bovara, a volte smarriti, irosi, assorti o beffardi in cui alcuni estimatori ritengono di percepire un impressionante sfaldamento di decomposizione e che altri interpretano invece come fiorente ricomposizione di elementi straniati, attestato di esuberante energia vitale, o altri ancora quali visibili, strazianti sedimentazioni di esperienze vissute, lotte nascoste, fuochi fatui di felicità, amori bruciati, effimeri successi, accumulate amarezze.
Non si tratta di una rassegna di stereotipi di fantasia: sono figure vive, tratte da una quotidianità che ci è contigua ma che nella indaffarata speditezza del vivere non ci soffermiamo a considerare. O forse scomode istantanee di quell’aspetto segreto di noi stessi che ci sforziamo di dissimulare sotto l’ipocrisia del quotidiano mascheramento. Intelaiature di anime scheletrite dall’incalzare di una angoscia esistenziale inconfessata che talvolta mette disperate radici di evasione che dal profondo si estendono in ramificate propaggini, esili braccia che si protendono verso un cielo muto, fiduciose in un’avvisaglia di misericordia e di tregua. Effigi di un’umanità infelice le cui flebili invocazioni si perdono in vastità siderali, nell’ostinato silenzio di un creatore che alimenta la convinzione maligna di una insensibilità illimitata e perpetua.
Bovara porta il peso di una lucida visione dell’intollerabile assurdità esistenziale, ma il potere esorcizzante dell’arte è che questa, anche quando racconti la tragica futilità del nostro destino, al tempo stesso la revochi, la differisca, reintegrandola e assolutizzandola nella forza delle immagini attraverso le quali restituisce loro la vita, provvisoriamente sottratta all’ineluttabilità di una fine.
Impermanence non è solo pregnante titolazione di un’apprezzabile opera di Bovara, ma il senso della dura lezione che la temporalità ci infligge, della condanna a quell’incessante divenire marcescibile e indecoroso che ci rende sgomenti prefigurando il sepolcro. Tale incontrovertibile, sconfortante realtà che l’artista ha designato quale tema fondante dei suoi non sempre accattivanti lavori, non discende da un capriccio del suo estro inventivo o da una sua scettica visione del mondo, ma dai drammatici effetti di una ben più remota, bizzarra “creazione” che solo qualche euforico buontempone può considerare perfetta.
L’arte non guarisce dalla sofferenza del vivere, di cui Bovara offre penetrante testimonianza. Solo l’arte tuttavia contiene quell’afflato imponderabile, quel segreto di seduzione, quella capacità di sublimazione in grado di arginare lo scoramento, additandoci – nella sua meravigliosa inutilità – un balenio di disillusa speranza.
Giovanni Serafini

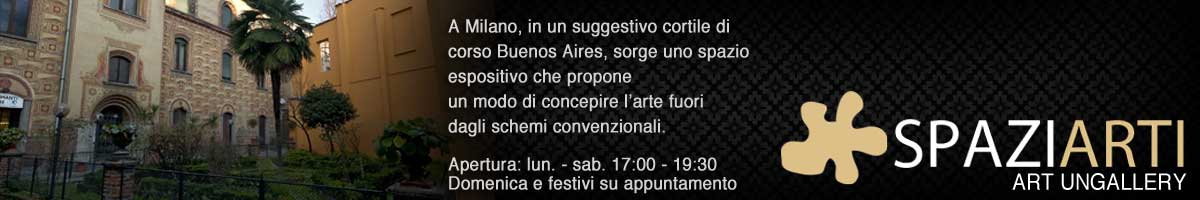




2.266 Comments
Trackbacks/Pingbacks